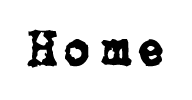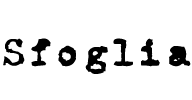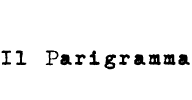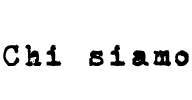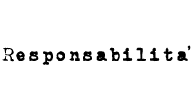Kalle, Bjorn, Lundmaar e Fredrik. Quattro come quattro sono
i nostri peggiori timori, quattro come quattro sono le nostre principali paure.
Quattro perché ognuno di loro può sembrare una di esse guardandoli. Quattro
perché è quattro il numero della fine per tutti gli occidentali. Quattro perché
è la sintesi dei nostri mali. Quattro perché sono le nostre dimensioni, anche
se undici sono dimostrate, quattro ne percepiamo.
Kalle, castano, dai lunghi capelli mossi, dalla robusta
struttura fisica e dotato di una buona altezza. Bello, di vent’anni. Il suo
viso ricorda quello di un angelo, che scivolato si chiude nel dolore
dell’inferno, ma rimane pur sempre, Lucifero, bello intelligente, seppur
nell’invidia. Dalla pelle chiara, dallo sguardo vitreo, sebbene gli occhi siano
castani, quasi verdi. Dalla bravura immensa nella musica, dalla scarsa
autostima. Dall’odio più profondo, per se stesso, a volte, per gli altri. Si esclude
dal parlare come se fosse una pestilenza la sua voce. Come se fosse un
incurabile morbo tutto ciò che pensa. Chiuso e silenzioso come un virus,
certamente freddo, ma capace di scaldare come un’ infezione. Kalle,
d’immancabile ausilio al mondo, per capirlo. Kalle, come il tempo può spurgare
ogni malessere, come il tempo invece annienta nella cancrena ogni essere
vivente. Kalle nella sua malattia la nostra vita. Lundmaar, magro fino alle
ossa. Si riescono a scrutare, guardando nella sua pelle dalle sue braccia.
Lunghi capelli castani, biondi un tempo, forse. Gli occhi verdi, il viso
scavato dalla fame, dai pensieri sulla vita, dallo studio di essa, dal proporre
una cura per se stesso e per gli altri. Tanto lunga la sua esistenza sul mondo,
tanto la lunghezza della sua chioma. Consumato dai bruciori gastrici per ogni
centimetro di ogni suo capello. Come tutti noi, con tal ulcera, al posto suo,
già li avremmo persi tutti. Fine e magre le dita delle sue mani, scavate le
fosse degli occhi. Quasi blu la sua carne, per via dell’evidenza delle sue
vene, rossa solo la sua bocca, come del sangue che solo li si percepisce
scorrere. Bocca usata per proferir parola, sapienza, conoscenza, come dolore su
di esse. Ordinato nella sua figura, come un medico, che cura se stesso,
tralasciando gli altri.
 A volte, perfino soffocandoli sotto la sua presenza.
Cercandoli poi, nell’ora della sua riconciliazione, discontinua quanto la sua
fame. Lundmaar, il cui nome si associa alla caverna dove rimane il suono della
sua musica. Quell’ombra di chi non vede nulla e non sente il sapore di nulla da
sempre. Il suo trono di ghiaccio dal quale canta sui morti. Bjorn, dalla pelle
abbronzata e scura, come di un uomo che vive nel vortice di ogni impulso. Dagli
occhi castani, più chiari dei suoi capelli, tagliati come la chioma dell’elmo
di Ares dio della guerra. Dal fisico longilineo, ma nerboruto, come solo la
furia disegna un uomo. Strano Bjorn, affascinante ma non bello. Pesante ed
immensa la sua collera, rivelata al mondo, dalla sua frenesia, dal suo vitale
scompiglio, dall’alterarsi continuamente, dall’andare e dal venire, dal non
ascoltare nulla, dal seguire se stesso fuggire come un nemico sul campo di
battaglia. Dall’inseguire la gloria, abbattendosi sul mondo, nemico di ogni suo
pensiero. Dal brindare come una divinità alla corte di belle donne, quasi come
dee, quasi come immortali, nella sua memoria. Di facili conquiste, brama e
vizio si mescolano nel fumo e nel suo amore per il verde e per la natura.
D’animo chiaro e deciso, come il rombo di un’esplosione. Come il sincoparsi del
suono della sua chitarra elettrica. Dal piacere nell’eccitare tutti in una
smorfia violenta spontanea quando si ascolta la sua presenza. Dall’ira viene
investito chi sente il suo urlo, chi rimane con lui, si sacrifica in una guerra
totale, che non lascia altro che la gloria della propria morte. Morte, Fredrik,
il suo specchio. Nulla di più appropriato che il becco d’un corvo che lo
annuncia, per descrivere la sua bocca, dai denti d’un lupo formata. Non uno di
dritto. Dal naso ambiguo e rotto, come d’un teschio, dal sorriso di lei, nella
sua danza macabra. Dai capelli lisci lunghi e scuri. Dalla pelle cianotica
d’inverno e rossa ed abbronzata d’estate. Scivoloso ed agile nell’essere sempre
accanto a chi vuole portare via nell’ombra. Alto eppure piegato, quasi gobbo,
perso ed attento, intelligente e scemo. Vivace e arcigno. Altero e spensierato.
Riflessivo ed impulsivo. Vivo ma morto. Fredrik, disgrazia per lui e per gli
altri. Insieme d’essere e non essere. Teschio bianco con carne ed occhi color
castano. Lineamenti dolci e freddi. Odioso alla luce ma amante del biondo come
il sole. Adorabile e sincero, come falso e tagliente. Serpente sia per saggezza
che per male. Bestia sia per cattiveria che per libertà. Spietato e
appassionato. Come chiunque sia morte ma respiri. Fredrik, colui che scrive del
senno e ne agisce il contrario. Fredrik, colui che suona bene quello che fa
schifo. Fredrik colui che s’ingegna nelle scienze come colui che ne disprezza i
risultati. Fredrik, la fine di tutto e niente. Come una domanda che ha in testa
e che si conclude con la stessa ad ogni risposta. Morte e nient’altro è Fredrik
che vi attende mentre aspetta se stesso. Chinato forse mentre piange e ride del
tempo, come un teschio che non può serrare le labbra.
A volte, perfino soffocandoli sotto la sua presenza.
Cercandoli poi, nell’ora della sua riconciliazione, discontinua quanto la sua
fame. Lundmaar, il cui nome si associa alla caverna dove rimane il suono della
sua musica. Quell’ombra di chi non vede nulla e non sente il sapore di nulla da
sempre. Il suo trono di ghiaccio dal quale canta sui morti. Bjorn, dalla pelle
abbronzata e scura, come di un uomo che vive nel vortice di ogni impulso. Dagli
occhi castani, più chiari dei suoi capelli, tagliati come la chioma dell’elmo
di Ares dio della guerra. Dal fisico longilineo, ma nerboruto, come solo la
furia disegna un uomo. Strano Bjorn, affascinante ma non bello. Pesante ed
immensa la sua collera, rivelata al mondo, dalla sua frenesia, dal suo vitale
scompiglio, dall’alterarsi continuamente, dall’andare e dal venire, dal non
ascoltare nulla, dal seguire se stesso fuggire come un nemico sul campo di
battaglia. Dall’inseguire la gloria, abbattendosi sul mondo, nemico di ogni suo
pensiero. Dal brindare come una divinità alla corte di belle donne, quasi come
dee, quasi come immortali, nella sua memoria. Di facili conquiste, brama e
vizio si mescolano nel fumo e nel suo amore per il verde e per la natura.
D’animo chiaro e deciso, come il rombo di un’esplosione. Come il sincoparsi del
suono della sua chitarra elettrica. Dal piacere nell’eccitare tutti in una
smorfia violenta spontanea quando si ascolta la sua presenza. Dall’ira viene
investito chi sente il suo urlo, chi rimane con lui, si sacrifica in una guerra
totale, che non lascia altro che la gloria della propria morte. Morte, Fredrik,
il suo specchio. Nulla di più appropriato che il becco d’un corvo che lo
annuncia, per descrivere la sua bocca, dai denti d’un lupo formata. Non uno di
dritto. Dal naso ambiguo e rotto, come d’un teschio, dal sorriso di lei, nella
sua danza macabra. Dai capelli lisci lunghi e scuri. Dalla pelle cianotica
d’inverno e rossa ed abbronzata d’estate. Scivoloso ed agile nell’essere sempre
accanto a chi vuole portare via nell’ombra. Alto eppure piegato, quasi gobbo,
perso ed attento, intelligente e scemo. Vivace e arcigno. Altero e spensierato.
Riflessivo ed impulsivo. Vivo ma morto. Fredrik, disgrazia per lui e per gli
altri. Insieme d’essere e non essere. Teschio bianco con carne ed occhi color
castano. Lineamenti dolci e freddi. Odioso alla luce ma amante del biondo come
il sole. Adorabile e sincero, come falso e tagliente. Serpente sia per saggezza
che per male. Bestia sia per cattiveria che per libertà. Spietato e
appassionato. Come chiunque sia morte ma respiri. Fredrik, colui che scrive del
senno e ne agisce il contrario. Fredrik, colui che suona bene quello che fa
schifo. Fredrik colui che s’ingegna nelle scienze come colui che ne disprezza i
risultati. Fredrik, la fine di tutto e niente. Come una domanda che ha in testa
e che si conclude con la stessa ad ogni risposta. Morte e nient’altro è Fredrik
che vi attende mentre aspetta se stesso. Chinato forse mentre piange e ride del
tempo, come un teschio che non può serrare le labbra.
Quattro storie, per quattro uomini. Quattro racconti per
ognuno di loro. Ma è pur vero che in fine, è sempre uno per tutti e tutti per
ogni racconto. Si parla di uomini e donne.
F.M.